Clirim Muça, poeta-editore al servizio della libertà
Nato in Albania, 20 anni fa decide di scappare all’estero passando per la Grecia e la ex Jugoslavia, a piedi, in pullman e in treno, fino a giungere in Italia. Vive e lavora in Toscana dove gestisce un piccolo albergo. Poeta, scrittore, drammaturgo e infine editore, si ritiene un perfetto autodidatta
 Clirim Muça nasce nel 1965 in Albania da una famiglia di contadini. Passa la sua infanzia e la giovinezza a Cerme – Lushnje, dove compie i suoi studi di scuola superiore.
Nel 1990 lo Stato e il Partito del lavoro gli concedono il diritto di continuare gli studi universitari alla facoltà di Agronomia a Tirana.
Nel 1991 decide di scappare all’estero passando per la Grecia e la ex Jugoslavia, a piedi, in pullman e in treno, fino a giungere in Italia, dove passa cinque lunghi anni di clandestinità.
Riuscito ad ottenere la regolarizzazione della sua permanenza in Italia, vive e lavora prima a Milano e poi in Toscana, dove, insieme alla moglie, gestisce un piccolo albergo a Castiglioncello, in provincia di Livorno.
Poeta, scrittore, drammaturgo e infine editore (visita il sito), si ritiene un perfetto autodidatta.
Clirim Muça nasce nel 1965 in Albania da una famiglia di contadini. Passa la sua infanzia e la giovinezza a Cerme – Lushnje, dove compie i suoi studi di scuola superiore.
Nel 1990 lo Stato e il Partito del lavoro gli concedono il diritto di continuare gli studi universitari alla facoltà di Agronomia a Tirana.
Nel 1991 decide di scappare all’estero passando per la Grecia e la ex Jugoslavia, a piedi, in pullman e in treno, fino a giungere in Italia, dove passa cinque lunghi anni di clandestinità.
Riuscito ad ottenere la regolarizzazione della sua permanenza in Italia, vive e lavora prima a Milano e poi in Toscana, dove, insieme alla moglie, gestisce un piccolo albergo a Castiglioncello, in provincia di Livorno.
Poeta, scrittore, drammaturgo e infine editore (visita il sito), si ritiene un perfetto autodidatta.Il suo primo libro "Tani gjerave u jap nje kuptim te ri" raccoglie versi in lingua albanese. Altri componimenti in versi sono: "Da oltre il mare", "Milano –Tirana senza ritorno" viene scritto insieme al poeta italiano Alberto Figliolia; le poesie vengono presentate con testo a fronte in albanese. "Grido", "Ombre sul mondo", "Naufrago a Cerme","L’animale triste", "Il breve volo","Fango di strada" una raccolta haiku e in fine "Poesie scelte" tutti in lingua italiana. Di narrativa sono invece "I racconti della terra dimenticata","Cento e una favola", "Le avventure di un mezzo gallo", "La lezione del lombrico". Per la rappresentazione teatrale e il cinema ha scritto "Il delirio di Adrasto e altri drammi", "Platone l’avrebbe chiamato amore", testi godibili anche nella semplice lettura.
Quando è nato il suo interesse per la letteratura e come si è sviluppato nel tempo?
«Sono cresciuto con le fiabe di mia nonna, depositaria del folclore del paese. Fino a dieci anni dormivo in stanza con lei, mi addormentavo con la sua voce nelle orecchie.
Il mio interesse per la letteratura è nato presto, nella mia giovinezza. Avevo 15 anni quando iniziai a scrivere poesie, prima di allora leggevo, ero un grande lettore di libri. Con la scrittura aumentava in me il desiderio di leggere, sempre di più».
Il contesto politico e sociale del suo Paese ha favorito la sua attenzione al mondo letterario o ci sono stati problemi? Se sì, di che tipo.
«La mia Albania di allora era una dittatura e le dittature sopprimono il pensiero libero, la libera iniziativa. Essere poeti in tempo di dittatura rende sospetti; per le autorità si diventa sovversivi, pericolosi. Il mondo letterario di allora era composto dalla Lega degli scrittori, organizzati e finanziati dal Partito. I poeti e gli scrittori non in linea con il pensiero del Partito venivano esclusi o peggio ancora additati come "nemici del popolo". I miei amici erano tra questi ultimi, che dopo la caduta del regime sono diventati nomi importanti della letteratura albanese: Zhiti, Jaçellari, Bali, Aliaj».
La sua formazione culturale ha potuto contare sulla conoscenza di autori stranieri?
«Sono un autodidatta. Ho imparato l’italiano con l’aiuto di un dissidente, A. Kolgjini, per poter leggere quei pochi libri che circolavano di nascosto. Libri ancora non sequestrati o sfuggiti alle retate del "Sigurim", l’allora polizia segreta. Era un modo per sconfinare con la lettura. Leggevo molto, i grandi della letteratura russa, francese, tedesca, inglese, italiana e naturalmente gli scrittori albanesi».
Quali hanno incontrato il suo favore e perché?
«Quando scopri un grande poeta, lo ami e basta! Perché la poesia è fatta così: nasce da un grande mistero ed esercita una forza misteriosa. I poeti e gli scrittori che amo? L’elenco sarebbe molto lungo».
La cultura, e in particolare la letteratura, di Albania quali riferimenti importanti hanno avuto e hanno? Quali sono secondo lei gli autori che meriterebbero una migliore conoscenza in Italia e in Europa?
«La letteratura albanese fin dai suoi inizi ha guardato all’occidente e alla sua letteratura. I primi libri tradotti in albanese sono stati quelli di Shakespeare, Goete, Cervantes. Citavamo Byron come se fosse un poeta nazionale. Con la dittatura i grandi della letteratura furono tollerati, ma non Dostojevski per esempio. Al lettore venivano proposti scrittori e poeti del realismo socialista, ma grazie alla ignoranza dei comunisti furono passati anche nomi come Essenin o altri che con il realismo socialista non avevano molto da spartire. Oggi la letteratura albanese è rigogliosa, in pieno sviluppo con nuove voci originali e importanti. Accanto a Kadarè e Agolli, Hajdari o Zhiti, ce ne sono altri, tanti altri, che è difficile nominare tutti, difficile comprendere in una sola antologia. Ci sono i poeti e gli scrittori che vivono in Albania, in Kossovo, ma molti di più sono quelli della diaspora che sfuggono a ogni catalogazione».
Come è stato il suo rapporto con la cultura italiana?
«Ho amato molto i poeti italiani fin da quando ho imparato a leggere in italiano. leggevo Dante e Petrarca a voce alta, senza capire granché. Mi ammaliava la musicalità della lingua. Poi ho scoperto Ungaretti, Montale e da quando sono in Italia Cardarelli, Betocchi, Merini. La letteratura e il fascino della sua lingua esercitano una grande attrazione per ogni poeta, di qualsiasi nazionalità lui sia».
Quanto ha contato e conta il nostro grande patrimonio per Muça autore?
«In questi ultimi anni mi cibo di cultura e letteratura italiana. Ho scelto di rimanere in Italia pur avendo la possibilità di andare in Austria o Germania, solo per la lingua e la vostra poesia. Nel mio piccolo, come poeta migrante, faccio parte del patrimonio italiano. L’italiano è la mia seconda lingua, e ha preso il posto della prima».
Secondo lei ne facciamo buon uso?
«In Italia, la cultura non è vista come una risorsa, ma quasi come un peso. La politica vuole una cultura sottomessa e servizievole come sono certi giornali e certi giornalisti. Le fondazioni culturali finanziate dai politici molte volte servono a questo scopo. Ma tutto sommato, la vera letteratura sopravvive ai cattivi governi».
Gli scrittori e i poeti di ieri che più apprezza?
«I nomi che ho detto prima, ma anche Quasimodo, Pavese, Calvino, Moravia e molti altri».
E quelli di oggi?
«Come scrittore, adoro Tabucchi, seguo Fo, apprezzo molto i poeti milanesi, Loi e Kemeny».
Varese ha una bella tradizione medica e scientifica, una forte e continua curiosità per la storia, designer di fama europea come Bertoni e Morandini, attori teatrali di fama internazionale, pittori e scultori di grande dignità e, in campo letterario, un eccellente scrittore come Piero Chiara e un poeta assai apprezzato come Vittorio Sereni. Sa che abbiamo poeti di spessore che da noi hanno un buon seguito da anni?
«Medici, scenziati, attori… speriamo che rimangano ancora a lavorare in Italia. Conosco Sereni, ma non Chiara. Cercherò subito di leggere le sue opere. Il problema della poesia in Italia è che molti di quelli che scrivono non leggono poesia. E’ come se un medico non leggesse più le riviste specializzate, uno scienziato non s’interessasse più delle nuove scoperte. Ci sono venti milioni di presunti poeti in Italia con un libro di poesie nel cassetto ma con nessun libro di poesia da leggere, sopra quel cassetto. Ecco perché si pubblicano tanti libri di poesie a pagamento e si vende così poco».
Mi sembra che un incontro con loro potrebbe essere interessante. Intanto lei si presenti, ci parli della sua poetica, dei temi preferiti, degli scopi che si propone.
«L’incontro tra poeti è contaminazione, nel senso buono della parola. Fa scaturire nuove idee, energie nuove, nuovi slanci. Ben vengano gli incontri con altri poeti. La mia poetica, i temi? Sono un poeta per ispirazione, lirico di scuola ungarettiana. Mi definisco un pessimista speranzoso, ma anche mistico, civile, arrabbiato a volte. I temi della mia poesia sono i soliti: l’amore, Dio, la madre, la patria, l’incertezza del vivere quotidiano, la tristezza del mondo. La mia poesia è la poesia di un esule, il poeta è un esule su questa terra, e parla alla gente delle verità, quelle ultime, che smuovono le coscienze e perciò fanno paura. Per fare un paragone, la poesia è il contrario della televisione».
Il termine poeta ha antica origine greca e veniva accostato a una funzione costruttiva. Ai nostri giorni un poeta che cosa può costruire?
«L’anima. E’ quello che manca oggi giorno. Viviamo in una società tecnologica, senz’anima, dove l’uomo si sta trasformando in un robot».
Clirim Muça è anche un editore che ha teso la mano a scrittori e poeti di qualità e la sua Casa Editrice Albalibri ha un catalogo sbalorditivo: raccoglie infatti più voci e messaggi che vengono dal grande pianeta letterario.
«Come editore faccio anche un lavoro di scopritore di talenti. Insieme al mio amico, il poeta Alberto Figliolia, abbiamo lanciato molti di loro, italiani e albanesi. Abbiamo dato vita alla collana sportiva, ma soprattutto alla collana haiku. Non esiste una letteratura haiku in Italia, noi la stiamo creando e completando.L’haiku ha delle regole precise, come le 17 sillabe e il kigo, il riferimento alla natura, che nella traduzione non sempre trovi. Per chi è interessato e vuole capire di più esiste la nostra collana "l’Universo degli haiku". Ma anche nel mondo degli haiku come quello della poesia, molti scrivono senza voler leggere. Invito tutti quelli che scrivono a leggere anche, leggere, ancora leggere, anche e soprattutto i contemporanei non pubblicizzati dalla tv. Le piccole fiere del libro sono un’occasione di scoperta».
Come e perché è diventato editore.
«Per non cadere nel tranello dell’editoria a pagamento, per dare una voce a tutti quelli come me, che altrimenti non avrebbero modo di parlare a un pubblico. Credo che questo suo grande slancio trovi radici anche in un amore infinito per la libertà».
Un mio amico albanese mi ha detto che il nome Clirim in italiano potrebbe essere tradotto come Libero.
«La libertà è come la salute, solo quando ci manca ci accorgiamo di quanto essa sia importante. Come i poeti. Essere poeta significa essere uno spirito libero, andare contro corrente, lottare per la giustizia, per la libertà quando essa viene intaccata. E oggigiorno succede spesso. Sotto i regimi totalitari di destra o di sinistra i primi ad essere eliminati sono stati i poeti, perché i poeti sono la coscienza del popolo, i primi da far tacere in un paese a regime totalitario. E’ successo, potrebbe succedere ancora. A prescindere dal mio nome, sono sempre al servizio della libertà».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su La triste carica dei 107: oltre cento cani in gabbia in una villa a Buguggiate
MARINAMDG su Tarip, le prime fatture fanno discutere. Coinger: "Una rivoluzione culturale"
AF--67 su Tarip, le prime fatture fanno discutere. Coinger: "Una rivoluzione culturale"
Ora-SiempreResistenza su Scambio acceso tra studente e presidente Anpi a margine di un incontro scolastico a Luino
lenny54 su Scambio acceso tra studente e presidente Anpi a margine di un incontro scolastico a Luino
Paolo0 su "Sapevo della mancanza di materiali negli ospedali della Sette Laghi, ma non quanto la situazione fosse tragica"











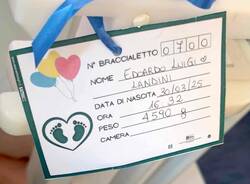



Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.